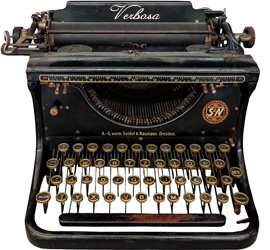Nell’articolo precedente (clicca qui per leggerlo) ho analizzato come la recente conclusione dell’accordo bilaterale tra Canada ed Unione Europea (CETA) abbia di gran lunga giovato alle indicazioni geografiche europee (di seguito IG), riconoscendone finalmente la tutela.
Cosa accade, invece, in America dove i supermercati pullulano di prodotti, ad esempio il “Parmesan Cheese”, che nulla hanno a che fare con le vere indicazioni geografiche ed il relativo disciplinare di produzione? Come mai le nostre eccellenze non vengono tutelate e, soprattutto, come è possibile che le aziende americane possano lucrare evocando in etichetta elementi italiani/europei ingannando, così, il consumatore circa la vera origine del prodotto?
Facciamo un passo indietro. E’ fondamentale inquadrare la questione all’interno del dibattito giuridico interno all’OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio) circa gli articoli 22 e 23 dell’accordo TRIPS (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – l’Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale). Nello specifico, ai sensi dell’art. 22 è vietato ingannare il consumatore sull’origine geografica del prodotto indicando che il prodotto in questione sia originario di un’area diversa dal vero luogo d’origine. Al contrario, l’art. 23 prevede una tutela maggiore, ma solo per i vini e le bevande alcoliche. Per esempio, secondo l’art. 22 è ammesso vendere un formaggio come “Grana Padano prodotto in Australia”, mentre, ai sensi dell’art. 23 è vietato scrivere in etichetta “vino frizzante tipo Champagne, prodotto in Cile”. Detto ciò, all’interno del dibattito mondiale, l’Unione Europea insisteva non solo per l’applicabilità dell’art. 23 a tutte le indicazioni geografiche, vini e non, ma anche per la creazione di un sistema di registrazione internazionale. D’altra parte, paesi come il Canada e l’America si sono sempre dimostrati restii.
Alla base di tali opposizioni, ovviamente, vi sono sempre stati grandi interessi economici: gli Stati Uniti continuano ad insistere sul non riconoscere le indicazioni geografiche europee sulla base dei numerosissimi e preesistenti marchi. Inoltre, gli Stati Uniti considerano come generici nomi che, invece, in Europa configurerebbero IG; ed anzi, al pari di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale conferiscono loro natura privatistica, differentemente dalla nostra regolamentazione.
Ne è seguita una vera e propria strategia politico-economica messa in atto dall’Unione Europea per la conclusione di accordi bilaterale che includessero anche la tutela delle IG. Esemplare è il caso del CETA: prima della sua conclusione il Prosciutto di Parma non poteva essere commercializzato in Canada a causa del preesistente marchio “Parma Ham” registrato dall’azienda Maple Leaf Food. Grazie all’accordo ora entrambi possono coesistere.
In conclusione, veniamo ora alla sistuazione negli Stati Uniti. Attualmente, l’unico sistema di tutela delle indicazioni geografiche è quello previsto per i vini, il cosiddetto “American Viticultural Areas” (AVAs). Nessuna tutela, al contrario, è data agli altri prodotti. La ragione è molto probabilmente culturale: gli Stati Uniti non hanno un patrimonio gastronomico così consolidato e specifico come i paesi europei. L’unico modo per poter risolvere la questione e tutelare le nostre IG in America sarebbe proprio la conclusione del TTIP e l’inserimento nello stesso, sulla falsariga del CETA, di un capitolo riservato alla regolamentazione delle indicazioni geografiche. Per arrivare a ciò, è chiaro che al tavolo delle trattative l’Unione Europea dovrà affilare le sue tecniche persuasive e diplomatiche ed insistere per la tutela delle nostre eccellenze.
Per maggiori informazioni scrivimi pure a cicogninimonica@gmail.com